
Se mi capiterà di avere un personaggio da far morire, credo che gli sceglierò un posto tipo qui da noi. In città non sarebbe la stessa cosa.
Prendi ad esempio la signora Gina, donna attempata e di anziana vedovanza, quei pochi che ricordano il marito dicono che era uno che stava zitto, un passo indietro, lei ha sempre tenuto le redini della casa. La signora Gina dunque, in un ipotetico racconto, è destinata a morire.
Morirebbe poi anche a Torino, l’Eguagliatrice è indifferente al luogo come alla stagione. Solo, se ne accorgerebbero dopo. Questo a motivo del fatto che la signora Gina ha sì un po’ di prole, ma all’atto pratico è come se non, essendosi i figli maritati in grandi città e lontane. Ogni sera, prima di coricarsi, riceve la telefonata della primogenita Cristina. Nonostante il travaso a Roma e le scuole alte, Cristina le parla ancora in dialetto:
“Mama, me ca va?”
L’inconveniente è che la Gina sarebbe sorda anzichenò, e vieppiù con l’età avanzante e l’ora serale: dunque quando Cristina non ricevesse risposta, immaginando la mamma in balcone o intronata dalla tivù, e considerata la distanza eccessiva per andarsi ad accertare di persona, riaggancerebbe con leggerezza. E le volte che tale defezione dal teleappuntamento si era verificata, sempre il giorno dopo la signora Gina aveva risposto col tono di chi non dà importanza all’esser sparita un giorno intero
“Fora dal let, preocupate nin”.
Quella sera, che muore, Gina non risponde più. Ma Cristina si preoccupa solo la sera successiva, chiama il fratello che sta più vicino, chiama magari qualche soccorso.
Se non fosse che noi del paese ci siamo già accorti. Le persiane sono rimaste chiuse al mattino, o addirittura aperte dalla sera prima. La Gina non si è vista al rosario a San Giuseppe, e nemmeno è passata stamattina dalla Fiore per il pane. Il cane abbaia, che non ha mangiato. E allora lo seguono gli altri, e da un capo all’altro del paese i cani strillano e ormai lo sappiamo tutti, che qualcosa è successo.
Penso che in via Tunisi a Torino sud non farebbero così attenzione alle persiane, che lì poi sono tapparelle. Se non altro, non sarebbe un evento notevole. Credo che tra i tanti clienti Carmen cassiera del Diperdì, se pure si accorge che la Gina non passa, non saprebbe come andarla a cercare. E poi, credo, i cani di città son più genati ad abbaiare.
Gina si sarebbe trasferita in via Tunisi da un paio d’anni, divenuto scomodo l’appartamento quasi centrale in corso Regina per via di ascensore assente e approvvigionamenti difficoltosi. Quando era giovane a Torino sud non c’era niente, non c’era neppure Torino, si andava là come in campagna a fare i scemi. Poi sono arrivati su in tanti, con le valige di cartone ma bravi che lavoravano, le loro madame pulite e in ordine con quel poco che avevano. Gli hanno fatto via Tunisi e le fabbriche lì vicino, e il mercato e i negozi, e adesso si sta più tranquilli lì che in centro. E infatti i vicini la trattano bene, le tengono la porta e dicono Signora quando viene e quando va. Non sono rumorosi, si fanno i fatti loro.
La Gina su da noi invece è nata in quella casona al 18, da allora hanno solo rifatto il tetto al fienile e allargato il muro dietro e messo il filo spinato che non vengano a rubare. Vi si è presa le sgridate dai genitori (poche, in verità), ci ha portato il marito a chiederla, che veniva da Asti ai tempi dei partigiani, ha poi tolto il nome del marito dalla buca, tenendone per lei il cognome di vedova. E ora ci muore anche lei. Quella casa è lei, si apre e si chiude coi giorni di lei, come a me dicono ancora “cul ca sta da la Celansa” che la Celanza è morta son vent’anni il mese prossimo.
Una volta che sentivamo battere la signora Gina, tum, tum, abbiamo proprio creduto chiedesse aiuto. Ci ha aperto coperta di sangue: stava facendo orrendo scempio di un coniglio, osso per osso, con la mannaia: venivano a trovarla i nipoti di Milano.
Il poliziotto che vien su da Torino per i seggi racconta le storie del suo lavoro, con un po’ di compiacimento a farle proprio da cinema. Richiesto se spesso veda cadaveri, dice trovarne ogni sera, che spesso chiamano lui a tirar giù porte più che i pompieri, e qualche volta pure è lì col morto e gli viene fame. Poi aggiunge che i poliziotti di qui non sono veri, vedono solo galline.
Ecco, a dover far morire la Gina, mi piacerebbe che poi chiamassimo il vigile di Salassa a fare l’irruzione. Che dopo torna a casa guardando basso e salta cena, e se la moglie gli chiede “E’ per le galline?” lui fa no e piagnucola: “Hanno chiamato me. E’ mancata la Gina”.
Suonano le campane:
“Chi ch’alé mort?”.
Dodici tocchi.
“L’è ‘na fumna”
E quando più tardi Battista e Raimondo, braccia dietro la schiena e cappello in testa, arrivano come ogni giorno a controllare i tiletti, trovano già gente davanti, e le macchine che rallentano per guardare l’affissione
Cristianamente è mancata all’affetto dei suoi cari
Luscietto Luigia detta Gina
ved. Canelli
e c’è anche la foto da una remota ridente mezzetà, che “A smia nen chila!” e Raimondo: “Quand che l’u coniussua a l’era parei!”. Al rosario, visto che manca lei che non ne perdeva mai uno, si usa che ci andiamo tutti del paese. Al funerale invece ci affacciamo dal giardino, perché il comune ha chiamato anche la banda (di Salassa anche quelli, come il vigile) per la sua concittadina antica.
Il punto chiave di mettere la Gina a morir da noi è che in città non ci sono i tiletti. Non sanno neppure che sono, tante volte. A che servono? Ci si telefona, o si fa l’annuncio sul giornale, e in un certo senso è il morto che ti deve venire a cercare sperando di interessarti. Come si fa con una festa. Oppure mettono il drappo davanti alla chiesa (ma quale chiesa?) e però quello lo facciamo anche noi.
Sotto l’occhio onnipresente del baffo Moretti, affacciato alle bottiglie da 66cl. condivise un bicchiere a testa, il bar della società commemora la signora detta Gina, pochi racconti in tutto, ma ripetuti.
Uno è quello del coniglio scempiato, di cui già si è detto.
Due che faceva la pipì sotto gli alberi in fondo al giardino senza curarsi se la vedesse qualcuno, che metteva su il falò a tutte le ore e così si distingueva casa sua fin da Belmonte, e insomma quel piccolo album che potremmo chiamare anedottica dell’orto.
Poi si parla della Gina in auto, nella fattispecie una vecchia 127 blu che doveva aver comprato usata da qualche giovanotto, per via di vistose griglie di raffreddamento cromate rievocanti il mondo delle corse, e due strisce adesive arancioni, fiammeggianti, che correvano parallele dal cofano al dietro. Ma lei guidava poi piano, sebbene con rombo da gara per via che mai, pare, andò oltre la seconda marcia, e stava alta e altera col volante schiacciato al petto. In città, avrebbe saputo di sicuro far di più coi motori, perlomeno usar le frecce e incolonnarsi, parcheggiare in retromarcia e riconoscere una precedenza. Avrebbe conosciuto fino ad inebriarsene i suoi diritti di automobilista e quelli di pedona, come certe signore cittadine che attraversano inopinatamente, o tengono la corsia di mezzo.
Solo che noi qui come scendi in strada hai già un po’ anche attraversato, e i nostri vecchi, a piedi o in macchina, conoscono un solo modo. Lento-avanti. E lei a Torino era stata solo nel ’46, in viaggio di nozze all’Hotel Miramonti camera 18. Così che lei diceva che tutto dove aveva abitato nella vita combinazione era al 18.
E questo del viaggio di nozze era il grande aneddoto di quella sera alla società, perché non è poi un’offesa ridere sui morti, e però intercalare sa di giustificazione: “Eh, buon anima”; e forse per levare a ognuno ogni colpa (tanto più bizzarramente tempore mortis) : “Eh, la vita è così”.
Ma poi si facevano anche i racconti più tristi, ritornando a casa perlopiù. Di quando lei diceva “Ma che il Signore mi prenda, che sto a fare senza nessuno?” e il Signore -visto?- l’aveva poi contentata. E poi della sua grande paura “Che i miei figli mi portino in qualche ricovero a Milano a Roma vicino a loro. Finché riesco a star sola, bene, ma poi voglio morire qui ”.
Credo che se non fosse un personaggio di un mio racconto, se fosse stata insomma una Gina vera, gli eredi l’avrebbero poi portata davvero al ricovero già da un po’, e mi immagino che sarebbe stata triste là, non brava a tenere compagnia e con il magone fisso al paese. Ma a me piace farla morire qui, che vero che morire è sempre dappertutto morire, ma almeno non di nostalgia.
Mi piace che lasci senza di lei un posto grande, come questa casona inutilmente a più piani, che io non conosco bene nessuno che ci sia entrato. E il giardino davanti e l’orto dietro, che ha lavorato fino al pomeriggio prima, e il ciliegio che sconfina dalla nostra nonostante il filo spinato, quindi a rigore mangiarne non è rubare. E adesso quando il pallone va di là potremo andarcelo a prendere, non come prima che aspettavamo ce lo ridesse (anche bucato, una volta che si era esasperata). Che lasci un posto grande, che faccia vuota una certa percentuale di paese, almeno per un po’.
Mi piace che vada a stare qui poco lontano, a far pieno un posto piccolo come piccoli quasi tutti i loculi del mondo, a meno che non si sia fatto un impero o smosso degli eserciti. Ma in un cimitero anche lui piccolo, vicino al marito buonanima-anche-lui e a gente che almeno di vista l’aveva conosciuta. Così che entrando vedi dove è la Gina, lì ci sono tanti fiori e i più freschi, almeno per un po’.
Questo, se mi capitasse un personaggio da far morire. Se invece si trattasse di innamorarmi, sceglierei diversamente. Come quando tre volte giro intorno al teatro a cercar posteggio, tu che mi aspetti sul marciapiede là davanti batti il piede. E tre volte mi punti addosso quello sguardo. Segui il mio ritardo, il mio guidare fieramente impacciato nel traffico. E quando trafelato chiedo “Scusa”, con quegli occhi mi dici ridendo “Campagnolo”.




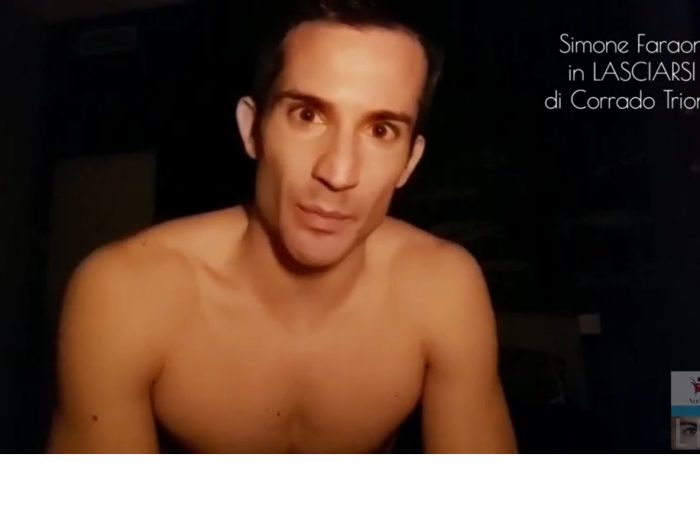



Febbraio 9, 2021
Thanks for your entire labor on this web site. My mother take interest in participating in research and it is simple to grasp why. My spouse and i notice all regarding the powerful tactic you produce useful thoughts via your website and in addition recommend response from the others on this subject then our own princess is undoubtedly studying a whole lot. Take pleasure in the rest of the year. You have been performing a terrific job. Allina Tobie Frear
Febbraio 12, 2021
I like the efforts you have put in this, regards for all the great articles. Sydelle Hill Chemush
Febbraio 12, 2021
So one way or another it looks like Scotland rates a big fat zero. Jacynth Tremain Muraida
Febbraio 17, 2021
I dugg some of you post as I thought they were handy very beneficial Fania Sawyer Amsden
Febbraio 28, 2021
whoah this weblog is fantastic i like reading your posts.
Stay up the great work! You realize, a lot of people are looking
around for this info, you could help them greatly.
Here is my web site :: CBD for sale
Febbraio 28, 2021
Having read this I believed it was rather enlightening.
I appreciate you taking the time and effort to put this short
article together. I once again find myself spending way too
much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!
Feel free to surf to my web blog: best cbd oil for sleep
Marzo 1, 2021
Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading
it, you will be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will often come back very
soon. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice day!
Marzo 1, 2021
I have fun with, lead to I found just what I was taking a look for.
You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a
nice day. Bye
Marzo 2, 2021
I visited many blogs except the audio quality for audio songs
present at this web page is really excellent.
Marzo 20, 2021
What i do not realize is in fact how you’re not really a lot more smartly-preferred than you might be now.
You’re very intelligent. You understand thus considerably with regards to this topic,
produced me personally imagine it from numerous various angles.
Its like men and women aren’t involved until it is one thing to accomplish with Woman gaga!
Your individual stuffs excellent. At all times take
care of it up!
Also visit my web blog :: cbd gummies
Marzo 22, 2021
It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a
doubt donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog
with my Facebook group. Talk soon!
My web page … cbd gummies
Marzo 30, 2021
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and
reporting! Keep up the amazing works guys I’ve included
you guys to my own blogroll.
Aprile 5, 2021
Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your submit is just nice
and i can think you’re knowledgeable on this subject.
Well together with your permission let me to take hold of
your RSS feed to stay updated with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the gratifying work.
Aprile 7, 2021
What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of
this website; this web site consists of awesome and truly good stuff in support of visitors.
Aprile 8, 2021
Magnificent website. Plenty of useful information here.
I am sending it to a few buddies ans additionally
sharing in delicious. And naturally, thank you on your effort!
Feel free to surf to my web site … best delta 8 thc carts
Aprile 8, 2021
I want to to thank you for this excellent read!! I certainly loved every little bit of it.
I’ve got you bookmarked to look at new things you post…
My page: delta 8 thc near me
Aprile 9, 2021
Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you
can be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and may come back
very soon. I want to encourage you to continue your great posts,
have a nice morning!
Aprile 12, 2021
Thanks for any other fantastic article. The place else may anybody get
that type of info in such a perfect approach of writing?
I have a presentation next week, and I am on the search for such information.
Feel free to visit my web site :: best CBD gummies
Aprile 12, 2021
I constantly emailed this website post page to all my associates, as if like to
read it then my friends will too.
Here is my web-site :: where to buy delta 8
Aprile 12, 2021
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You definitely
know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you
could be giving us something informative to read?
Also visit my web-site; CBD gummies for sale
Aprile 13, 2021
Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There’s a lot of people that I think would really enjoy your
content. Please let me know. Many thanks
Here is my homepage – cbd for sale
Aprile 13, 2021
Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know
a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure
why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show
the same results.
My page :: cbd gummies
Aprile 14, 2021
I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and amusing,
and without a doubt, you have hit the nail on the head.
The problem is an issue that not enough men and women are
speaking intelligently about. I’m very happy I came
across this in my search for something concerning this.
Stop by my website – CBD gummies for sleep
Aprile 14, 2021
This paragraph will help the internet people for creating new website or even a blog from
start to end.
Here is my web site; cbd for sale
Aprile 16, 2021
I just could not go away your site before suggesting that I extremely enjoyed
the usual information an individual provide to your guests?
Is going to be back steadily to check out new posts
Feel free to surf to my web site: buy delta 8 THC area 52
Aprile 17, 2021
Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and
include approximately all significant infos. I’d like to
see extra posts like this .
My homepage: buy delta 8 THC area 52
Aprile 17, 2021
I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility problems?
A few of my blog audience have complained about my website not operating correctly
in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this problem?
My website: delta 8 carts
Aprile 17, 2021
Instagram takipçi sayını arttırmak için her gün 1.000 adet takipçi alabilir ve güvenilir işlemler yürütmek için yönergeni Türkiye’nin en büyük etkileşim sitesi takipbonus.com’a çevirebilirsin!
https://cutt.ly/instagram-takipci-satin-al
Aprile 17, 2021
This is the perfect web site for everyone who hopes to find out about
this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not
that I personally would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for ages.
Excellent stuff, just wonderful!
Also visit my web page; where to buy CBD
Aprile 18, 2021
Hola! I’ve been following your web site for a while now and finally got the
courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!
Just wanted to mention keep up the good work!
delta 8 THC area 52 – delta 8 THC area 52
delta 8 THC area 52 – delta 8 carts Area 52
area 52 delta 8 THC products – delta 8 THC for sale area 52
Area 52 Delta 8 THC – buy delta 8 THC area 52
Area 52 delta 8 carts – delta 8 area 52
Aprile 26, 2021
Instagram en ucuz takipçi fırsatlarıyla sizde sosyal medyanın gücün elinize alın! Tamamı gerçek ve organik paketlerle popüler olmanın keyfini yaşayın!
https://www.facebook.com/hashtag/takipbonus Orijinal takipçileri en cüzi miktarlarla satın alın! https://smedusa548.wixsite.com/takipbonus bütçenizi zorlamayın! https://6083671c5895c.site123.me/ En iyisi olmak için çaba sarfedin!
Aprile 27, 2021
When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Thank you!
Have a look at my web blog :: cbd for sale
Aprile 27, 2021
Instagram organik takipçi ve beğeni paketi satın al!
Aprile 28, 2021
Geceleri canın sıkılıyorsa hemen instagram takipçi sayını arttırmaya başla!
Aprile 29, 2021
Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through
this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
Thanks for sharing!
P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t.
Keep up the good work!
Visit my page … delta 8
Aprile 29, 2021
Tiktok takipçi satın al. Avantajlı yeni Tiktok paketiyle, hızlı ve güvenilir: Tiktok takipçi satın al.
Aprile 30, 2021
I am grateful to you for this beautiful content. I have included the content in my favorites list and will always wait for your new blog posts.
Maggio 1, 2021
It’s hard to find experienced people on this topic, but
you seem like you know what you’re talking about! Thanks
P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if
you can’t.
Keep up the good work!
my homepage :: buy instagram followers
Maggio 1, 2021
I used to be suggested this blog by means of my cousin. I’m now not positive
whether this post is written through him as no one else realize such precise about
my problem. You are wonderful! Thanks!
Take a look at my web page delta 8 thc
Maggio 2, 2021
I am grateful to you for this beautiful content. I have included the content in my favorites list and will always wait for your new blog posts.
Maggio 5, 2021
I am grateful to you for this beautiful content. I have included the content in my favorites list and will always wait for your new blog posts.
Maggio 5, 2021
I am grateful to you for this beautiful content. I have included the content in my favorites list and will always wait for your new blog posts.
Maggio 7, 2021
En güncel haberler, son dakika gelişmeler ve tamamı gerçek internet haberleri https://www.gundemtube.com/kategori/haber/ adresinde sizi bekliyor!
Maggio 8, 2021
Dünyanın en iyi instagram takipçi satış sitesi http://bit.ly/takipci-satin-alin senin popülerliğini arttırmak için var!
Maggio 8, 2021
Türkiye’nin en iyi fiziki sosyal medya danışmalı https://www.fbtakipci.com size uygun fiyattan takipçi pazarlamak için var!
Maggio 8, 2021
İnstagram izlenme satın al! İzlenme satın al sayfamız ile kolayca video izlenme satın al anında organik görüntülenme gönderir!
Maggio 9, 2021
Sosyal medya danışmanları hizmetiyle sosyal medya danışmanı tutun ve sayfalarınızı, sosyal medya hesaplarınızı en etkili şekilde yükseltme ve ilerletmenin keyfini sürün!
Maggio 12, 2021
En ucuz tiktok takipçi ile organik takipçi sayını arttır ve tiktok ucuz takipçi siparişi vermek için http://bit.ly/tiktok-ucuz-takipci tiktok ucuz takipçi satın al!
Maggio 12, 2021
En ucuz Sosyal medya hesabın için aktif gerçek https://takipbonus.gq/ instagram hızlı ve şifresiz takipçi satın alabilirsin! Burası sana göre!
Maggio 14, 2021
En ucuz Sosyal medya hesabın için aktif gerçek https://takipbonus.gq/ instagram hızlı ve şifresiz takipçi satın alabilirsin! Burası sana göre!
Maggio 14, 2021
Organik takipçi arttırmayı hedefleyen müşteriler:
Takipçi satın almalı mıyız? Takipçi satın alırsak ne kadar sürede etkisini görürüz? İnsanlar takipçi sayısını arttırmak için takipci kullanımını seçiyor ve prestijli bir hesaba dönüşmek adına instagram takipçi satın al paketlerinden yararlanıyor. Sende indirimleri kaçırma ve instagram takipçi satın al!
Maggio 15, 2021
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home a
little bit, but instead of that, this is great blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
My page – casino utan svensk licens
Maggio 15, 2021
Kendini iyi hissetmen için instagram takipçi satın alabilirsin.
Tam kapanmaya özel indirim sağlayan ve tüm servislerinde %15 indirimi müşterilerine tanıyan takipcisanati.com ile büyük kitlelere kısa sürede ulaşabilirsin. Dünyanın her yerinden en ucuz paketleri sizlere tedarik eden panelimiz 7-24 anlık işlem garantisi vermektedir. Dünyanın en iyi takipçi satın al firmasıyla sende bir adım ileriye yürü!
Maggio 15, 2021
Türkiye’nin en kaliteli takipçi arttırma ve beğeni yükseltme sitesi fbtakipci firması sizin ve çevrenizin popüler bir medyaya sahip olması için çaba sarfetmektedir.
Maggio 15, 2021
Türkiye’nin en kaliteli takipçi arttırma ve beğeni yükseltme sitesi fbtakipci firması sizin ve çevrenizin popüler bir medyaya sahip olması için çaba sarfetmektedir.
Maggio 16, 2021
Kaliteli bir panel mi arıyorsun?
İnstagram takipçi satışı için geliştirdiğimiz takipbonus güvenli bir araştırma hazırlıyor ve müşterilerin isteyeceği türden Organik etkileşim zincirleri kuruyor. Sabırsız bireyler içim süper hızlı takipçi kazandıran web sitemiz instagram takipçi satın al konusunda dünya markası olmuş durumda. Sizde en yüksek miktarda paketleri bile takipçi bonus üzerinden ucuz fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Maggio 16, 2021
Instagram takipçi satın alma için izleyeceğiniz adımlar ile sizde garantili yükseliş yaşarken takipçim düşecek mi gibisinden telaşlardan kaçınacak ve güvenilir yollarla Instagram takipçi satın al avantajlarını öğrenmiş olacaksınız.
Günümüz teknolojisinde Instagram nimetlerini kullanıcılara açık kaynak sunduğu için tüm insanlık özgürce fotoğraflarını yayabiliyor, hikayelerini arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve karşılığında Beğeni, Yorum, Paylaşım gibi etkenlerle isimlerini duyurabiliyorlar. Elbette tüm bu adımlar öncesi takipçi sayınız en göze çarpan yerlerden birisi çünkü insanlar profilinizi ziyaret ettiği takdirde ilk göz atacakları yer kitleniz ve takip ettiğiniz kitle ortalamasıdır.
Maggio 18, 2021
Türk takipçi satın al! Instagram takipçi satın alma sitesi tr.takipbonus ile ucuz takipçi siparişi oluştur!
Maggio 19, 2021
Ucuz ve uygun fiyata türkiyenin en kaliteli instagram takipçi hizmetinden yararlan. Hemen takipçi satın al sayfamız aracılığıyla gerçek ve etkili takipçi siparişi ver!
Maggio 20, 2021
Takipçi satın alımı yapmak için istediğin paketi seç ve ödeme yöntemlerine göz at!
Maggio 20, 2021
Ucuz ve uygun fiyata türkiyenin en kaliteli instagram takipçi hizmetinden yararlan. Hemen takipçi satın al sayfamız aracılığıyla gerçek ve etkili takipçi siparişi ver!
Maggio 21, 2021
Nice articles bruh! Like and favorite list add!
Maggio 21, 2021
Nice articles bruh! Like and favorite list add!
Maggio 22, 2021
Nice articles bruh! Like and favorite list add!
Maggio 22, 2021
En uygun fiyata türkiye’nin gelişmiş takipçi kazandıran https://t.ly/gosL sitesi üzerinden instagram takipçi satın al! Popülerliğe her geçen gün daha yakından yanaş!
Maggio 23, 2021
Umduğunuzdan daha fazlasını sunuyoruz! Tek tıkla takipçi satın al hizmetiyle gerçek ve etkili yükseliş vaat ediyoruz!
Maggio 23, 2021
Umduğunuzdan daha fazlasını sunuyoruz! Tek tıkla takipçi satın al hizmetiyle gerçek ve etkili yükseliş vaat ediyoruz! http://takipci-satin-al.tk/
Maggio 24, 2021
En iyi takipçi satış sitesi ile takipçileri tek tıkla satın al anında gelmeye başlasın!
Maggio 25, 2021
Günün güzelliğini hissetmek ve özel bir kişi olmak için takipçi satın alabilirsin.
Maggio 25, 2021
Gramtakipci hilesi gramtakipci instagram takipçi hilesi!
Maggio 25, 2021
En iyi takipçi satış sitesi ile takipçileri tek tıkla satın al anında gelmeye başlasın! http://bit.ly/takipci-satin-al-murosmm
Maggio 26, 2021
İnstagram takipçi satın al, İnstagram takipçi satın al ucuz, ucuz İnstagram takipçi satın al, instagram ucuz takipçi! https://takipci-satin-alcam.blogspot.com/
Maggio 26, 2021
İnstagram takipçi satın al, İnstagram takipçi satın al ucuz, ucuz İnstagram takipçi satın al, instagram ucuz takipçi! https://bit.ly/takipci-pw-takipci-satin-al
Maggio 27, 2021
Tiktok izlenme, tiktok takipçi, beğeni, instagram satın al! http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://takipci.pw/kategori/tiktok-takipci-paketleri/
Maggio 28, 2021
Türk gerçek beğeni ve organik beğeni paketleri! http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://murosmm.com/
Maggio 28, 2021
Türk gerçek takipçi siparişi ver! http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://murosmm.com/
Maggio 30, 2021
En hızlı takipçi kasma uygulaması https://bit.ly/takipci-kasma-hilesi
Maggio 31, 2021
Spotify Organik takipçi sitemize bekleriz.
Giugno 1, 2021
Tiktok takipçi hizmeti veriyoruz!
Giugno 2, 2021
İnstagram takipçi hizmeti veriyoruz! http://bit.ly/takipci-satin-alcam
Giugno 2, 2021
Takipçi satın alınca ne olur? İnstagram takipçi satın alma esnasında destek almak için tıklayın; https://takipbonus.com/blgi/
Giugno 2, 2021
Sosyal medyada takipçi satın almak için tıklayın. http://globedia.com/takipbonus
Giugno 3, 2021
Sosyal medyada takipçi satın almak için tıklayın. https://onedio.com/profil/instagram-takipci-satin-al
Giugno 3, 2021
I pay a visit daily some web sites and sites
to read articles, however this webpage provides feature based posts.
Here is my web page … situs daftar judi slot online
Giugno 3, 2021
Hello! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
My website covers a lot of the same subjects as yours and I
think we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
Also visit my blog post: thc gummies
Giugno 3, 2021
Hi there Dear, are you actually visiting this web site on a regular
basis, if so afterward you will absolutely take nice knowledge.
my homepage: Best Delta 8 THC Gummies
Giugno 3, 2021
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
Also visit my page: delta 8 gummies near me (http://www.sfexaminer.com)
Giugno 5, 2021
Takipçi satış ve takipçi pazarlama şirketi.
Giugno 5, 2021
Takipçi satış ve takipçi pazarlama şirketi.
Giugno 6, 2021
Blog nice articles! Favorite add.
Giugno 7, 2021
Free Followers? Bot instagram followers no password!
Giugno 8, 2021
Nice articles! Favorite add and blog love.
Giugno 8, 2021
En hızlı instagram takipçi satın al
En uygun instagram takipçi satın al
En telafili instagram takipçi satın al
En gerçek spotify takipçi satın al
En ucuz instagram takipçi satın al
En otomatik instagram takipçi satın al
En sistematik tiktok takipçi satın al
En otantik instagram takipçi satın al
En opsiyonel instagram takipçi satın al
En güçlü instagram takipçi satın al
En kuvvetli instagram takipçi satın al
En seri instagram takipçi satın al
En akıcı instagram takipçi satın al
Giugno 9, 2021
En hızlı Takipçi hizmeti için tıklayınız; https://takiphilecin.com/
Giugno 10, 2021
Nice post brother takipci satin al
Giugno 10, 2021
Nice post brother takipci satin al
Giugno 21, 2021
This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I have shared your website in my social
networks!
Visit my blog – Observer
Giugno 21, 2021
Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the
favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its
ok to use some of your ideas!!
Feel free to visit my blog – Instagram followers (Fabian)
Giugno 21, 2021
Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort
to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a
whole lot and don’t seem to get anything done.
Also visit my web blog :: Instagram likes
Giugno 21, 2021
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything.
Nevertheless just imagine if you added some great images or video clips
to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and
videos, this blog could certainly be one of the greatest in its field.
Amazing blog!
My homepage – Instagram followers
Giugno 21, 2021
Very nice post. I certainly appreciate this
website. Keep writing!
My blog post … delta 8 CBD (http://www.thedailyworld.com)
Giugno 24, 2021
Excellent site. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few friends ans additionally sharing
in delicious. And obviously, thank you on your sweat!
Here is my web blog – best cannabis vapes (http://www.heraldnet.com)
Giugno 24, 2021
Amazing things here. I’m very happy to see your article. Thank you so much
and I’m taking a look ahead to touch you. Will you please drop me a
e-mail?
Also visit my page weed gummies
Giugno 27, 2021
En ucuz fiyata en organik paketler ile hizmet vermekteyiz.
Giugno 28, 2021
[url=https://lendpi.com/]loan locations[/url]
Giugno 29, 2021
Tamamı iyi ve en yeni paneller ile instagram takipçi satın al! Kendini yükselt!
Giugno 29, 2021
oo Nice broo
Giugno 29, 2021
oo Nice broo
Giugno 29, 2021
Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read
more news.
Also visit my blog post; Best THC Gummies
Luglio 1, 2021
En güçlü hayran kazandıran web siteye sahibiz!
Luglio 4, 2021
Güzeller içinde bir seni sevdim, kalbimi sana, ben sana verdim.
Luglio 6, 2021
Thank you blog, very nice article!
Luglio 6, 2021
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also
make comment due to this good post.
Take a look at my blog: tiktok followers
Luglio 6, 2021
[url=http://cialisms.com/]cialis tablet price in india[/url] [url=http://ivermectinextra.com/]stromectol ireland[/url] [url=http://viagragenpills.com/]can you buy viagra in australia over the counter[/url] [url=http://priviagra.com/]viagra pill cost usa[/url] [url=http://viagrahey.com/]over the counter female viagra[/url] [url=http://fviagra.com/]viagra brand canada[/url] [url=http://sslpills.com/]buy cheap levitra uk[/url] [url=http://clviagra.com/]no prescription viagra canada[/url] [url=http://viagrasn.com/]viagra rx price[/url] [url=http://ivermectintb.com/]stromectol coronavirus[/url]
Luglio 6, 2021
[url=http://oralcialis.com/]buy cialis 20mg tablets[/url] [url=http://clviagra.com/]viagra canada fast shipping[/url] [url=http://modafinilpls.com/]generic modafinil online[/url] [url=http://adopharmacy.com/]pharmacy online track order[/url] [url=http://viagragenericdiscount.com/]viagra 100mg mexico[/url] [url=http://safeviagra.com/]purchase viagra uk[/url] [url=http://viagragenpills.com/]25 mg viagra price[/url] [url=http://genmodafinil.com/]where to buy modafinil[/url] [url=http://buyviagranorx.com/]cheap viagra[/url] [url=http://sildenafilcitratepill.com/]best sildenafil brand[/url]
Luglio 7, 2021
Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I will revisit once
again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the
greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.
My web site … HeraldNet
Luglio 7, 2021
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It’s the little changes that will make the largest changes.
Thanks a lot for sharing!
Also visit my blog post – where to buy weed near me
Luglio 7, 2021
I was wondering if you ever considered changing the layout of your website?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
My site where to find weed
Luglio 7, 2021
[url=https://cialisism.com/]cheapest cialis 20mg[/url] [url=https://viagraubi.com/]where to buy female viagra in australia[/url] [url=https://pharmtp.com/]lasix 115[/url] [url=https://emcialis.com/]can you buy tadalafil online[/url] [url=https://tiqpills.com/]prednisone 20 mg buy online[/url] [url=https://viagragenericdiscount.com/]best viagra pills online[/url] [url=https://viagraqtab.com/]viagra 100mg pills generic[/url] [url=https://cialistip.com/]generic cialis pills online[/url] [url=https://ivermectintb.com/]stromectol tab price[/url] [url=https://sildenafilbest.com/]sildenafil pharmacy uk[/url]
Luglio 7, 2021
It’s the best time to make some plans for the long run and
it is time to be happy. I have learn this submit and if I could
I desire to suggest you some interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles regarding this article.
I want to read even more things approximately it!
my homepage … buy weed online
Luglio 8, 2021
Superb, what a webpage it is! This webpage gives valuable data to
us, keep it up.
my homepage; buy weed (heraldnet.com)
Luglio 8, 2021
En güzel izmir escort bayanların platformu!
Luglio 8, 2021
Nice blog, favorite list add thanks.
Luglio 10, 2021
Hello friends, nice article and nice arguments commented
here, I am genuinely enjoying by these.
My blog; buy weed online
Luglio 11, 2021
[url=https://orderviagratabs.com/]cheap viagra 100mg online[/url]
Luglio 12, 2021
Nice blog! Thanks you all star articles good story!
Luglio 18, 2021
En güzel bayanlar izmir escort sitesi ile bir tık uzağınızda! İzmir Escort bayanlar sitesi.
Luglio 19, 2021
Over the four decades to be stripped of their Mount Pleasant Indian Industrial Boarding School operated in Michigan, thousands of Native American children from across the country were taken from their parents and languages and traditions.
Luglio 24, 2021
Örneğin zayıflamak için içerisine sumak ve limon eklenmiş ya da kan yapıcı olsun diye keçiboynuzu pekmezi karıştırılır. Kalsiyum, protein, magnezyum, potasyum, A, E ve B vitamini grupları bakımından oldukça zengindir.
Agosto 1, 2021
İnstagram takipçi satın al En ucuz Örneğin zayıflamak için içerisine tek dava takipci satın al sumak ve limon eklenmiş ya da takipçi satın al kan yapıcı olsun diye keçiboynuzu pekmezi karıştırılır. takipçi satın al
Agosto 5, 2021
İnstagram takipçi hilesi tamamı otomatik ve hızlı instagram takipçi kasma servisi! takipçi yükseltmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Agosto 6, 2021
Eskort bayan güzel izmir Eskort bayan burada! Eskort bayan sitesi ile izmir Eskort bayan bulabilirsiniz.
Agosto 7, 2021
instagram-takipci-satin-al.com ile en doğal İnstagram takipçi satın alma paketlerini inceleyin. Kaliteli ve güvenilir instagram takipçi paketleri web sitemizde sadece Sipariş verilmek için bekliyor. Üstelik %100 Doğal ve Şifresiz teslimat özellikleriyle.. Anında İnstagram takipçi satın alabilirsiniz!
Agosto 8, 2021
Thank you.
My site: bit.ly/takipci-satin-al-murosmm
İnstagram takipçi satın al..
Agosto 9, 2021
Tempore mortis | Dimenticando Francesca
anygjmwvzy
[url=http://www.g9l558135bx4msvkdg568op2wxs3086ps.org/]unygjmwvzy[/url]
nygjmwvzy http://www.g9l558135bx4msvkdg568op2wxs3086ps.org/
Agosto 14, 2021
Playlistim yemyeşil. Thanks.
Agosto 15, 2021
If you want to connect with TikTok fans, you are going to need to have some great content on hand.
Agosto 15, 2021
80mm 5m Chain Color Zinc
Agosto 16, 2021
Tiktok takipçi al! En ucuz tiktok takipçi al! Kaliteli tiktok takipçi al!
Agosto 18, 2021
İnstagram takipçi satın al .. Takipçi satın al ve İnstagram takipçi satın al!
Agosto 18, 2021
3d Embroidery Cap
Agosto 19, 2021
Yeni İstanbul Escort Bayanlar ♥ İstanbul Escort Ara !
Agosto 19, 2021
Enteral Drainage Bags
Agosto 20, 2021
3 Piece Dining Set
Agosto 20, 2021
Takip satin al, hemen takip satin al, takipsatinal ile takipsatinal.
Agosto 20, 2021
Synchronized Road Stud
Agosto 20, 2021
Takip satin al, hemen takip satin al, takipsatinal ile takipsatinal.
Agosto 20, 2021
12mm Thick Toughened Glass
Agosto 21, 2021
5mm Rubber Underlay Manufacturers
Agosto 21, 2021
Sodium Bicarbonate Price
Agosto 22, 2021
10% Borocic Hdpe Sheet
Agosto 22, 2021
Construction Waste Compost Making Machine
Agosto 22, 2021
Many thanks for this excellent post.
Agosto 23, 2021
Glazing Bead Cutting Machine
Agosto 23, 2021
Flooring Vinyl Plank
Agosto 23, 2021
Air Line Hose
Agosto 23, 2021
https://takipavm.com/youtube-karsilikli-abone-kasma-sitesi/
Agosto 24, 2021
İnstagram beğeni satın al, hemen beğeni satın almak için tıkla!
Agosto 25, 2021
BXL
Agosto 25, 2021
Takipci satın al sitemiz cok iyi çalışır. Öyle iyidir ki takipci alarak büyümek mümkündür. Trmedya yapımı olan bu kaliteli site ile sende instagram takipçi arttır!
Agosto 26, 2021
Günlük yaşantımız ile sosyal medya iç içe geçmiş durumda, milyonlarca insan Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlarda aktif olarak paylaşımlarını sürdürmektedir. Sosyal medya sitelerine her gün bir yenisi eklense de son günlerin en popüler platformu açık ara Instagram’dır.
Agosto 26, 2021
Straight Lucky Bamboo
Agosto 26, 2021
https://takipavm.com/instagram-havale-ile-takipci-satin-al/
Agosto 26, 2021
Günlük yaşantımız ile sosyal medya iç içe geçmiş durumda, milyonlarca insan Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlarda aktif olarak paylaşımlarını sürdürmektedir. Sosyal medya sitelerine her gün bir yenisi eklense de son günlerin en popüler platformu açık ara Instagram’dır.
Agosto 26, 2021
Cnc Press Brake
Agosto 27, 2021
Takipçi at, takipçi yükle hemen takipçi kas. İnstagram takipçi yüklet.
Agosto 27, 2021
Automotive Collision Repair
Agosto 28, 2021
Industrial Gearbox Services
Agosto 29, 2021
Cas:3612-20-2
Agosto 31, 2021
I finally saw those who viewed my twitter profile
Settembre 1, 2021
En iyisi instagram videoları seyretmek! Güncel videolar ile hd kalitede kalitelitakipci seyredin.
Settembre 2, 2021
4 Panel Sliding Glass Door Factory
Settembre 3, 2021
En ucuz seanslar burada! En iyi dert edinmeler, en iyi kış geçirmeler.
Settembre 3, 2021
do you have this on instagram?
Settembre 3, 2021
Sabit instagram kullanıcıları takipçiye pek önem vermez, fakat kişisel hesapların bile etkileşimini arttırmak için instagram takipçi sayısının yüksek olması gereklidir. Profilinize türk gerçek takipçi sipariş ettiğiniz zaman beğenileriniz artar, paylaşımlarınız yorum toplar ve doğal olarak yeni arkadaşlar kazanırsınız. İnstagram takipçi yükseltmenin en faydalı olduğu yerlerden birisi de işyeri hesaplarıdır. Markanızı bir adım ileriye taşıyacak İnstagram’da takipçi satın al paketlerini kullanarak siparişlerini ve kazancını arttırabilirsin.
Settembre 4, 2021
Instantly Uploaded I’m here now??
Settembre 4, 2021
Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu Pornocu
Settembre 5, 2021
Drip Pipe
Chanelシャネル指輪スーパーコピー
Settembre 6, 2021
portable toilet bathroom
Gucciグッチスマホケーススーパーコピー
Settembre 7, 2021
LouisVuittonルイヴィトンバッグスーパーコピー
portable toilet for construction site
Settembre 11, 2021
Arrived 10 minutes later my followers thank you
Settembre 11, 2021
Burberryバーバリーブランドコピー代引き
At Home Dna Extraction Lab
Settembre 11, 2021
Mustafa Tugrul Yılmaz – Ellerini Kaldır ve TESLİM OL ! OROSPU CUCUGU
Settembre 11, 2021
Rolexロレックス財布コピー
Reishi Mushroom Powder
Settembre 13, 2021
Din Pn16
ブランドSaintLaurentサンローラン財布コピーN級品
Settembre 13, 2021
Chanelシャネル財布コピー
Multi Tube Heat Exchanger
Settembre 14, 2021
Omegaオメガ時計コピー
Circular Saw Blade For Aluminum
Settembre 15, 2021
Türk ve aktif güvenilir takipçi, takipavm’de! Sende gel ve güvenilir takipçi satın al.
Settembre 15, 2021
eski sevgiliye ne denmeli 🙂
Settembre 15, 2021
Goyardゴヤール財布スーパーコピー
Industrial Portable Lock Box
Settembre 15, 2021
Thanks very interesting blog!
my page cbd capsules for pain
Settembre 15, 2021
Wow, superb blog layout! How long have you ever been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content material!
Settembre 15, 2021
instagram takipçi satın al sitesi sizlerle! İnstagram takipçi sayısını yükseltmek isteyen kullanıcılar için en güvenilir instagram takipçi satın al sitesi hizmet vermektedir. İnstagram profiline akış olmasını istiyorsan eğer yapman gereken tek şey instagram takipçi satın al paketlerini incelemektir. En ucuz instagram takipçi satın al paketlerini al ve hesabını fenomen hale getir.
Settembre 15, 2021
I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
I am hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now
😉
Here is my web-site – Where To Find Delta 8
Settembre 15, 2021
Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search
Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
If you know of any please share. Thanks!
Here is my webpage; maeng da [http://www.bellevuereporter.com]
Settembre 20, 2021
Would you like tea or coffee, Stalkers?
Settembre 21, 2021
instagram i�inde olani varmi bunun ?
Settembre 24, 2021
ulan 2 yildir takip edermi bir insan
Settembre 24, 2021
Who exits after logging in to the site?